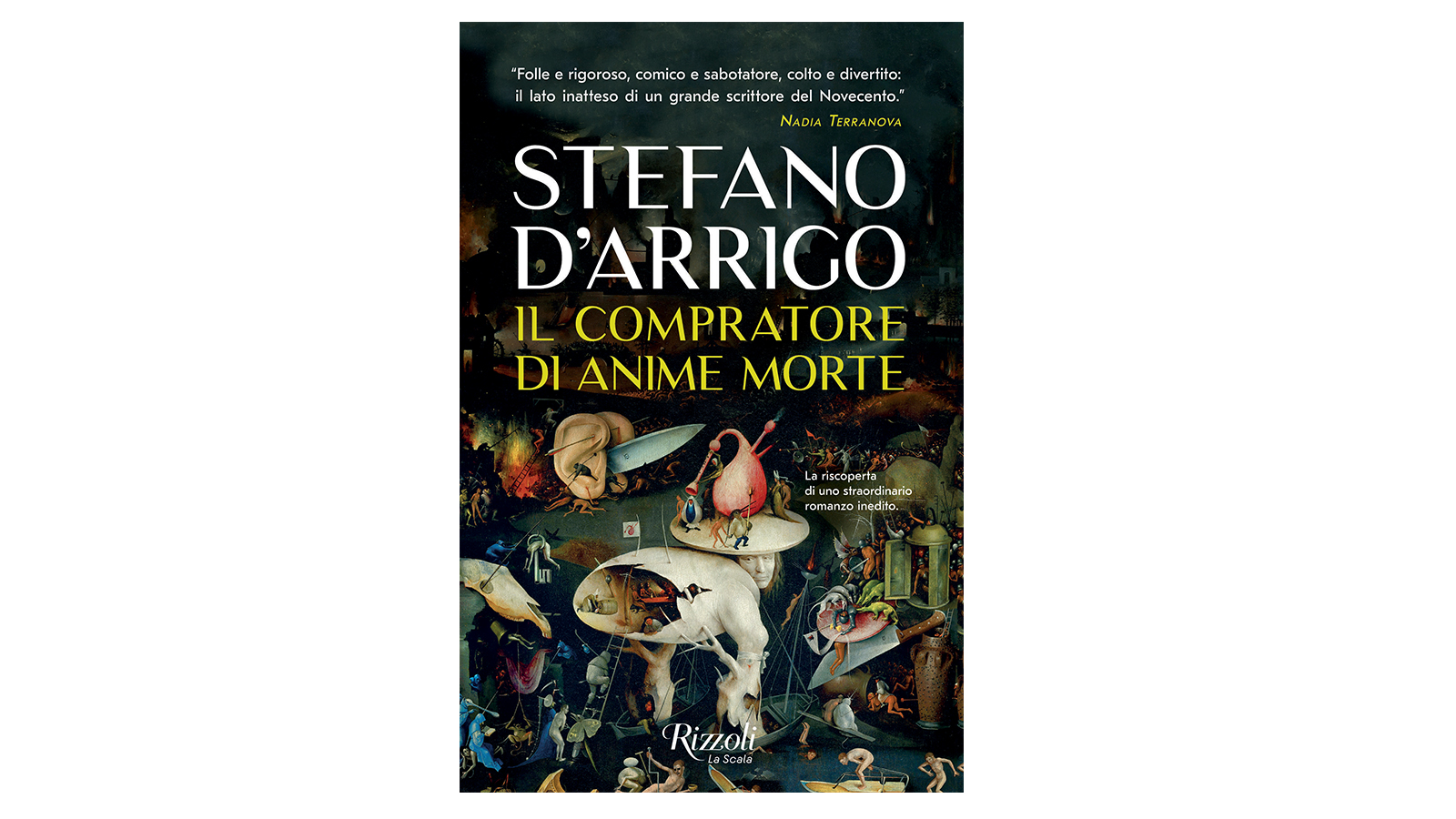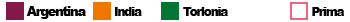documenti collegati
A cura di Luca Doninelli
Perché hai scelto un testo difficile come Macbeth, un testo che, tradizionalmente, gli attori interpretano malvolentieri?
La prima risposta, ovvia, è che per molti aspetti Macbeth è il più grande testo di Shakespeare. Lo è nel senso che è il meno scontato, il meno consaputo. Si pensa che sia una sorta di parabola sul potere, per intenderci alla Riccardo III - al quale è stato accostato da alcuni - mentre non è affatto così. Questo mi ha affascinato. Più lo leggevo e rileggevo, e più mi appariva chiaro che conteneva una sfida
Quale sfida?
Macbeth è, per gli attori cui tocca interpretarlo, il personaggio più problematico e in qualche modo il più sfortunato. La sua natura non è tanto la brama di potere, quanto piuttosto una certa propensione alla fantasia. Macbeth è prigioniero dell’immaginazione. Non è intelligente, non sa usare la ragione, è schiavo del suo immaginario, e dico “schiavo” nel senso letterale del termine, in quanto questo immaginario, anziché allargare le sue vedute, le restringe fino a impedirgli qualsiasi altro modo di esistere.
E la sfida dove sta?
Sta nel fatto che l’attore che lo interpreta deve comunicare allo spettatore un certo senso di compassione.
La morte di Macbeth ha sempre destato compassione.
Non è questo che intendo. Io parlo di com-passione, che è un patire insieme, ossia il coraggio di dare a sé stessi i medesimi sentimenti dell’altro. Macbeth non è un assetato di potere, è un uomo che avanza nel sangue, ma non con uno scopo. Non è nemmeno un uomo coraggioso, tant’è che in diversi punti del dramma viene preso dalla tentazione di esaurire i suoi misfatti nell’atto di immaginarli. La funzione delle streghe (che lui chiama sorelle) e di Lady Macbeth è quella di far procedere questa sua immaginazione dentro la realtà: un procedere che però non ha nulla di fiero, di spavaldo, ma è piuttosto come una continua caduta in avanti. Ha bisogno di qualcosa che lo rimetta sempre in moto, che lo costringa a svolgere qualcosa che esiste dentro di lui, ma che stenta ad uscire.
Torniamo alla compassione
Nulla a che vedere con la pietas. Lo spettatore dovrebbe desiderare di imitarlo. Chi di noi non ha mai desiderato ammazzare qualcuno? Chi di noi non ha cresciuto dentro di sé, magari per poco, un nemico mortale? Questa è la sola catarsi possibile in un testo come Macbeth. Lo aveva capito bene Nietzsche. Del resto, non vorrei aver latto male Aristotele, ma anche per lui la catarsi è questa cosa: non diventare migliori, ma riconoscersi peggiori.
A quale personaggio della letteratura accosteresti Macbeth?
Nessun dubbio: al capitano Achab di “Moby Dick”. Il luogo della tragedia macbethiana non è il castello, è la brughiera, nella quale il protagonista avanza come in un mare. Anche lui solo: proprio come Achab. Anche lui prigioniero di una visione.
Se al centro del “Macbeth” non c’è il potere, se “Macbeth” non c’entra con Riccardo III, qual è il tema centrale di questo dramma?
I protagonisti sono due: il tempo e la magia. La brevità del testo è dovuta alla necessità di far precipitare tutto senza mai ragionare o progettare quello che accade.
E la magia?
La magia, rappresentata soprattutto da Lady Macbeth, che è una esperta di droghe. Le sue misture possono indebolire oppure accendere l’animo, o ancora riempire la testa di allucinazioni. Lo scopo di tutto questo è trasformare la realtà in una sorta di continuazione del sogno. Se i nostri progetti devono fare i conti con gli imprevisti della realtà, la magia, il sortilegio servono a eliminare gli imprevisti - cioè a eliminare la realtà. Macbeth avanza nel sangue come dentro un sogno dal quale non ci si desta più.
Da cosa nasce questo atteggiamento?
Dalla paura della vita, dalla paura della realtà. Come tanti assassini, Macbeth è un vigliacco: non ama il mondo, non ama stare al mondo, anzi, diciamo meglio: Macbeth non sta bene nella creazione. Per questo è un distruttore della vita: perché ne ha paura. Questo fa di lui un sanguinario, ma un sanguinario speciale. Macbeth infatti non è un uomo crudele alla maniera di certi intellettuali, teorici del crimine, o della frode, come Iago o Riccardo III. Non è sanguinario per un progetto di potere, ma per terrore. La grande scommessa dell’attore è di produrre, nello spettatore, una com-passione, un patire-insieme con questo tipo di umanità, che in fondo ci somiglia più di Iago. Se dovessimo identificarci con un personaggio negativo, noi vorremmo somigliare a Iago, o a Stalin, o a Goebbels perché non ne andrebbe del nostro amor proprio. Ma proprio per questo il mio sospetto è che in realtà la parte peggiore di noi sia più simile a Macbeth: una crudeltà vile, pavida, senza dignità.
E’ questa la natura del male?
Io credo di sì. O meglio: credo che le cose stiano così perché il male non ha natura, è non-natura.
News
-
Visita spettacolo al Teatro India
-
Il compratore di anime morte
-
“L’eco der core” Roma com’era, Roma com’è nei testi e nelle canzoni di Roma
-
Visita spettacolo al Teatro India
-
Una giornata fatale del danzatore Gregorio Samsa
-
Roma in versi
-
È nato il nuovo canale Instagram della Fondazione Teatro di Roma!
-
Teatro di Roma, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
-
Il Teatro di Roma diventa Fondazione
-
Carta Giovani Nazionale
-
Art Bonus - Sostieni il tuo teatro!